Prendi le miserie umane. Guardale bene, con l’occhio freddo dello statistico, dello scienziato attaccato al microscopio. Renditi conto che non esiste mai niente di grandioso, che i veri atti di eroismo sono minuscoli e che l’unica cosa che può essere davvero ciclopica, nell’uomo, è la codardia. Aggiungi dolore, morte e disillusione, un pizzico di irridenza verso la religione, una secchiata di consapevolezza di come sia impossibile scampare al destino e inquadra tutto in pagine di un lirismo che commuoverebbe anche le pietre. Ecco quello che fa Camus, ecco la sua Peste.
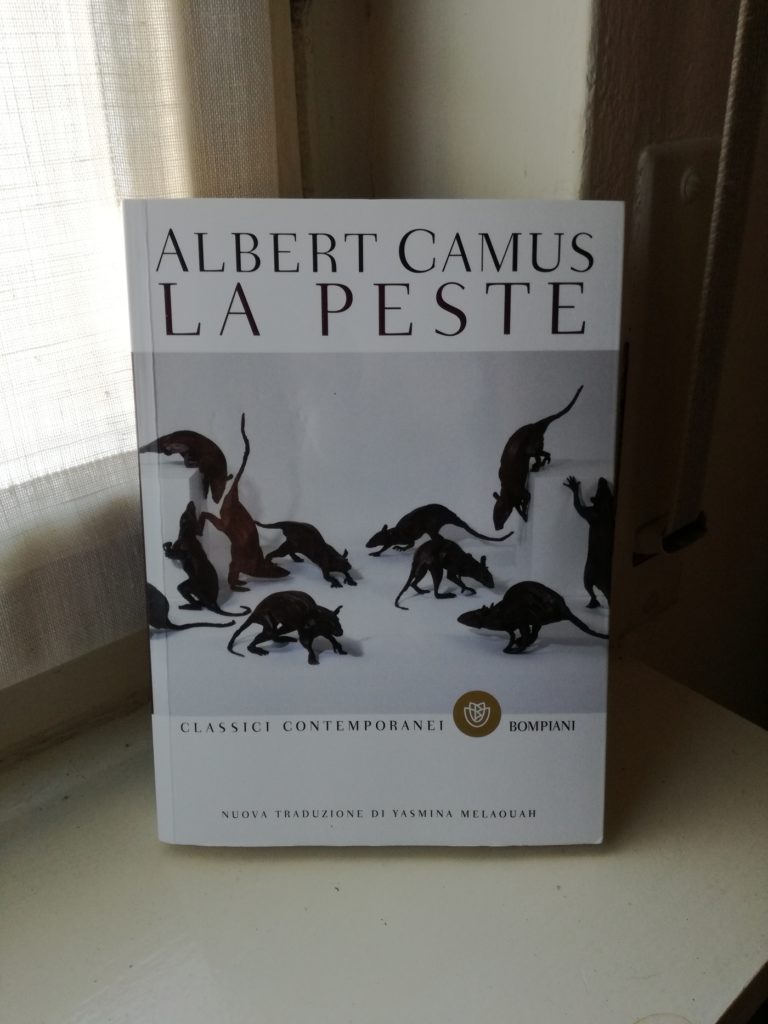
Questo libro l’ho comprato al supermercato, che è una cosa che non faccio quasi mai, ma quelli di Bompiani sono stati davvero bravi: bella copertina, tema attuale, prezzo abbordabile. Non ho avuto scampo.
La Peste parla appunto di una peste. Quella vera, bubbonica. Negli anni quaranta una città dell’Algeria francese diventa focolaio del contagio e, per protocollo sanitario, viene isolata. Il romanzo si sviluppa nell’arco di un anno (grossomodo), che è appunto la durata dell’isolamento. Immagina di essere rinchiuso in una cittadina di provincia per un anno. Per forza poi hai delle crisi esistenziali.
I disordini alle porte, che avevano costretti i gendarmes a fare uso delle armi, crearono una sorda agitazione. C’erano stati senz’altro dei feriti, ma in città tutto veniva ingigantito per effetto del caldo e della paura e si parlava di morti. È pur vero che il malcontento cresceva e che le nostre autorità, temendo il peggio, avevano valutato seriamente le misure da prendere nel caso in cui la popolazione, oppressa dal flagello, si fosse lasciata andare alla rivolta.
Il romanzo è raccontato dal punto di vista di un “cronista”: uno dei protagonisti decide di mettere per iscritto quello che è successo. Lo fa dopo, a tragedia finita, perché vuole salvare almeno qualcosa dell’ordalia collettiva. E lo fa soprattutto compiendo un giuramento di neutralità: egli appunto si definisce cronista perché dichiara di avere intenzione di riportari i fatti, senza abbellimenti e senza cedere alla facile enfasi che glorifica i sopravvissuti.
In realtà a parlare non è il cronista, ma Camus stesso, e subito si capisce cosa pensi della vita, l’universo e tutto il resto. In estrema sintesi: è facile essere dei santi, estremisti, senza sfumature, andare in fondo e magari farsi ammazzare per un ideale. È difficilissimo stare in mezzo, “essere medici”, fare del bene materialmente e nel proprio piccolo e non venire travolti.
Il romanzo è discretamente corale, ci sono sei protagonisti e ciascuno ha la sua testa, i suoi demoni e il suo modo di affrontare il dolore, la lontananza dalla persona amata, le prospettive. C’è il padre gesuita che arriva, ragionando, alla conclusione che un prete non dovrebbe andare dal medico, perché una malattia in generale e un flagello come la peste in particolare non può che essere volontà divina, e solo nell’abbandono alla volontà divina c’è redenzione. C’è il vecchio asmatico che conta i piselli e ci regala i due, tre rarissimi momenti leggeri del romanzo. C’è l’impiegato-comunale-scrittore-di-belle-speranze che anche nel mezzo della catastrofe si ossessiona sull’incipit del suo romanzo. E poi ci sono i protagonisti “grossi”, quelli che proprio affrontano a facciate il tema del dolore, del ruolo dell’uomo, della morte. Lo fanno in maniera straordinariamente francese, da film in bianco e nero con i protagonisti avvolti dal fumo di sigaretta che si scambiano dialoghi brevi e pieni di pause.
Insomma, è un romanzo intenso, i temi non sono leggeri e magari uno non ha voglia, legittimamente, di immergersi in una pesata. Però è Camus. Una pagina sì e una no ho sottolineato cose, una frase, la scelta di un aggettivo. L’ho letto in traduzione, va bene, ma comunque da una lingua neolatina e non, come al solito, dall’inglese. Si sente. Le parole sono al loro posto, non un aggettivo sbavato, e soprattutto Camus ci dice cose interessanti. Anche quando descrive un paesaggio. Anche quando descrive un’atmosfera, eterea, sfumata, indefinibile.
Oh, non è un romanzo perfetto, specialmente se calato nella chiacchiera odierna delle tensioni sociali. Si notano due cose, cioè l’assenza di donne e l’assenza di arabi. Le uniche due donne sono comparse minori e mi pare non abbiano neanche nomi, restano “la madre di” e “la moglie di”. Spesso di parla di donne lontane, per cui struggersi, senza però mai vederle in azione. Uno dei protagonisti, Rambert, ruota proprio attorno a questo, a quanto sia dolorosa la separazione. Per quasi tutto il romanzo Rambert cerca di scappare clandestinamente dalla città, ed è occasione di affrontare la tensione tra interessi privati e collettivi, senza arrivare peraltro a una risposta definitiva.
Gli arabi e in generale gli algerini dovrebbero esserci, ma non sono quasi mai nominati, se non in brevi passaggi, sullo sfondo, per fare colore. Perché?
Non è facile dare una risposta certa parlando di un romanzo che ha come tema centrale l’impossibilità – l’assurdità, anche – di trovare delle certezze. Una risposta possibile è che il romanzo parli in realtà della seconda guerra mondiale, e in particolare dell’occupazione tedesca della Francia. È facile trovare i parallelismi, volendo. I nazisti sono appunto la peste, che arriva e ammazza, rinchiude le persone nelle case e svuota gli animi. Quelli che in questa situazione prosperano (come Cottard, il trafficone) sarebbero i collaborazionisti. Il già citato gesuita fa una predica e dice che “Fratelli, la sventura vi ha colpito, fratelli, ve lo siete meritato”, ed è facile interpretare il passaggio come una critica ai francesi che si sono lasciati travolgere, accecati dalla superbia, incapaci di valutare il pericolo e di reagire. E anche la gloriosa Résistance non ne uscirebbe benissimo, a dirla tutta: il monumento ai coraggiosi caduti della peste, che verrà eretto a breve dopo la conclusione della vicenda narrata, è un monumento alla gente che non ha imparato proprio nulla.
Io non sono sicuro al 100% di questa interpretazione del romanzo come grande metafora, ma se anche fosse così, se Camus aveva in testa le vicende francesi, a dire la verità non importa: la Peste è, senza mezzi termini, permanente. Non scappa e non se ne va, perché non scappa e non se ne va l’animo umano, di cui il romanzo è appunto una pulitissima cronaca.
E mentre svoltava nella via di Grand e di Cottard, Rieux pensava fosse giusto che almeno ogni tanto la gioia ricompensasse coloro che si accontentano dell’uomo e del suo povero e terribile amore.
Albert Camus
La peste
Bompiani editore
